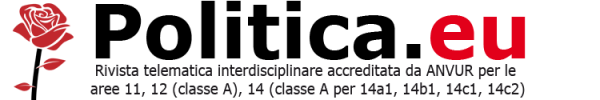Call for papers: Assoluto, soggettività, libertà. Dieter Henrich (1927-2022)
La libertà può essere compresa solo in un contesto che presuppone il pensiero dell’assoluto, qualsiasi cosa con esso si voglia intendere? Se, per qualunque autentico percorso di conoscenza, di ricerca, di impegno pratico con la realtà, è dalla libertà che si deve cominciare, vuol dire che a sua volta la libertà è teoreticamente pensabile, ed esistenzialmente, socialmente, politicamente possibile, solo come presenza di un assoluto in seno al relativo? Accogliere l’invito di Dieter Henrich a tematizzare la libertà in una prospettiva essenzialmente e genuinamente metafisica equivale a porre le premesse concettuali di un ripensamento del soggetto, e in particolare del soggetto di diritto, in quanto espresso da un’istanza che lo supera, e allo stesso tempo in quanto capace di esprimere tutta la complessità antropologico-filosofica, e la profondità spirituale, dell’esistere come singolo con – e tra – altri singoli, nella dimensione del linguaggio, come nelle strutture etiche, istituzionali e normative della vita civile.
15 aprile 2024
Il termine di scadenza per la sottomissione degli articoli, da indirizzare a redazione.rivistapolitica@gmail.com,
è il 31 dicembre 2024.
Lingue: italiano, tedesco, inglese, francese, spagnolo